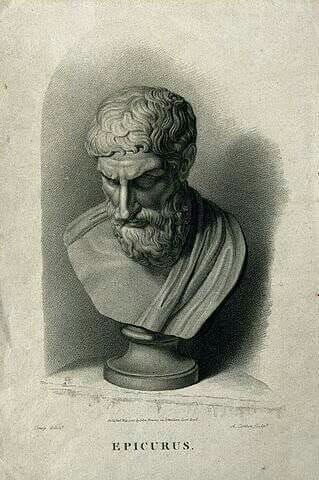In un mondo in cui la morte spaventa tanto quanto attrae, non sono mancati i pensatori che hanno cercato di capirla, di spiegarla o almeno di accettarla. Nella storia della filosofia, si è formato un vero e proprio dualismo: da una parte chi la considera un male assoluto, qualcosa da temere; dall’altra chi la interpreta come una liberazione. Due visioni opposte, ma entrambe profondamente umane. Un importante pensatore ad analizzare la morte fu Thomas Hobbes, filosofo inglese del Seicento, il quale credeva che la morte rappresentasse il male più grande. Nel suo pensiero, l’essere umano è mosso principalmente dal desiderio di sopravvivere e dal timore di morire in modo violento. Proprio la paura della morte spinge gli uomini a riunirsi e creare lo Stato, affidando il potere a un sovrano, chiamato da Hobbes “Leviatano”. Per Hobbes, vivere è mantenere l’ordine, morire è tornare nel disordine. La morte, dunque, non redime: spaventa, limita e accompagna l’uomo nel caos, ma al tempo stesso lo porta a convivere con gli altri. Un’idea opposta la vediamo in Arthur Schopenhauer, due secoli dopo. Filosofo del pessimismo, Schopenhauer vede la vita come un ciclo di desideri e sofferenze: appena otteniamo qualcosa, nasce subito un nuovo bisogno. Dietro tutto questo c’è la “volontà di vivere”, una forza cieca che ci spinge a esistere e a desiderare senza sosta. Ecco perché, per lui, la morte non è il male supremo, ma la liberazione da questo meccanismo infinito di dolore. Quando la ricerca del desiderio si spegne, anche la sofferenza scompare. Schopenhauer non invita a cercare la morte, ma a riconoscerla come parte naturale della vita. Hobbes e Schopenhauer ci mostrano due volti opposti della stessa medaglia. Nonostante ciò, la morte resta una libertà temuta, una soglia che ci fa paura, proprio perché, in fondo, promette qualcosa che non conosciamo e non possiamo controllare.