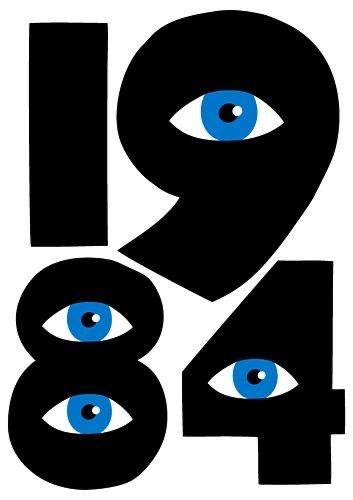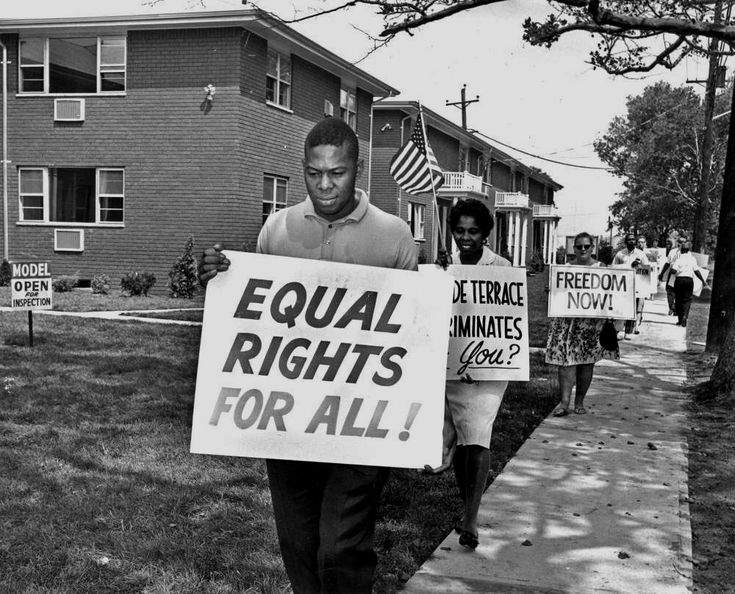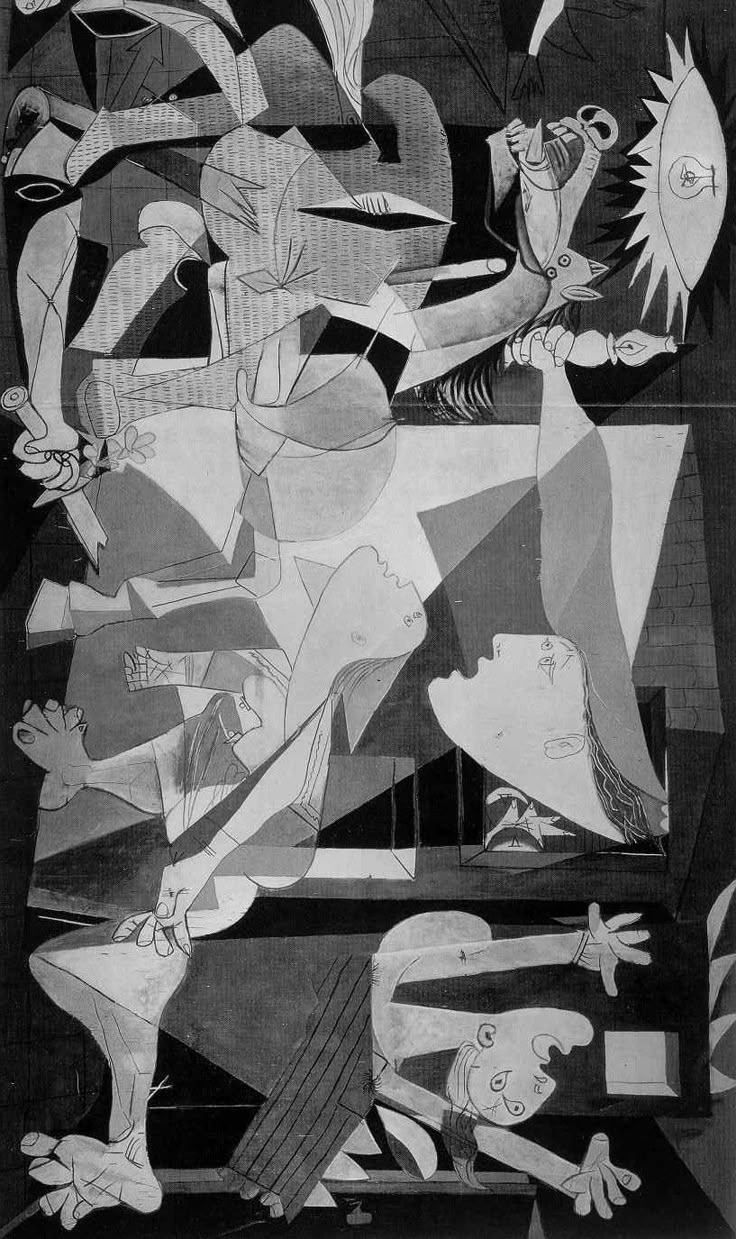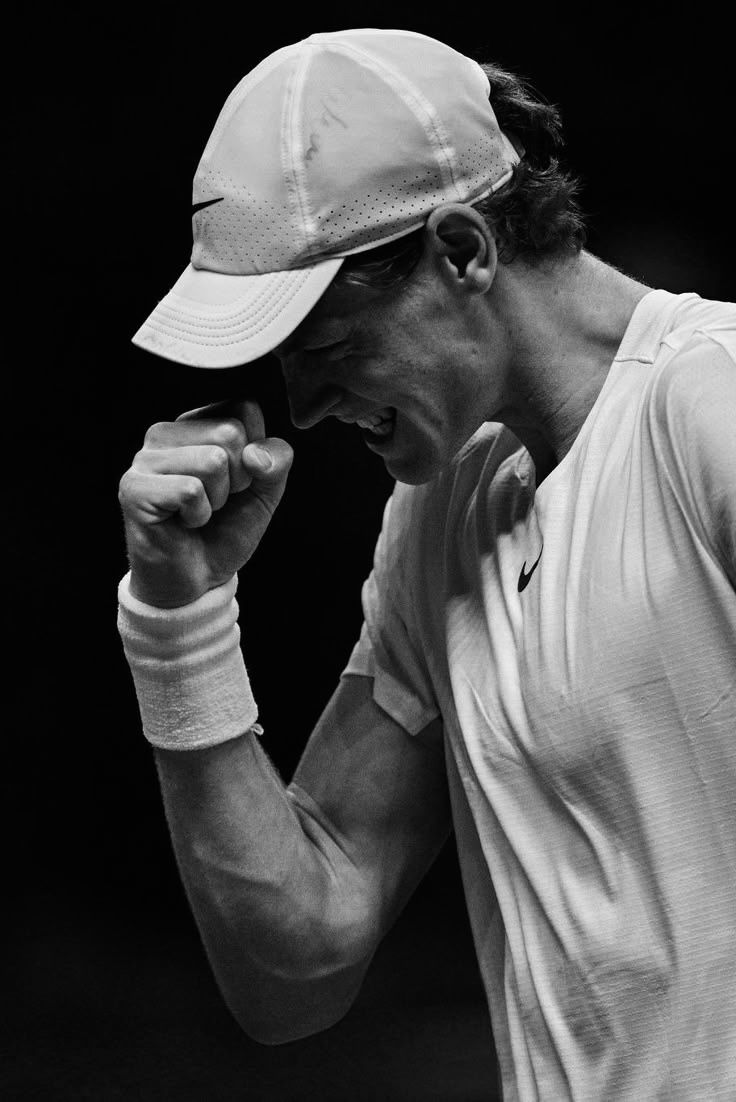Se sia la realtà ad influenzare la letteratura o viceversa rimane tuttora un mistero. In un momento in cui psicologi e psichiatri sono sempre più richiesti, in libreria sembrano comparire soprattutto titoli che rispecchiano l’isteria generale, tra saggi freudiani e romanzi strazianti con protagonisti che sembrano farsi gara a chi ha subito più traumi. Le storie d’amore, per quanto molte indicate come tali non meritino l’appellativo, non sono un’eccezione. La gran parte di queste narra di rapporti disfunzionali, dipendenti, ossessivi: basta aprire un libro di Sally Rooney per rendersene conto. Inoltre, come in molti non compresero “Lolita”, così la denuncia degli autori moderni viene spesso ignorata, se non colta a rovescio. Vittima di questo fenomeno di mistificazione è, spesso, il dolore femminile, come ha brillantemente narrato Jeffrey Eugenides ne “Le vergini suicide”, storia di cinque ragazze oppresse dalla vita, narrata da alcuni ragazzi “innamorati” di loro.
Alienazione, malessere e disturbi non sono una novità nella letteratura, anzi: non è necessario guardare lontano per trovare somiglianze tra le ultime uscite e i capolavori del passato, da “Anna Karenina” a “La coscienza di Zeno”. Con il recente successo di titoli come “Una vita come tante”, “Il mio anno di riposo ed oblio” e “Persone normali”, non sorprende quindi la ritrovata popolarità di autori come Franz Kafka, Sylvia Plath e Virginia Woolf, le cui tragiche vite ed opere non smetteranno mai di commuovere. Tra ottimi esempi di prosa e poesia moderna, tuttavia, si nascondono spesso autori incapaci che hanno compresso che oggi, forse, bastano frasi e versi dalla parvenza tragica per avere successo tra i giovani.